
polemiche e delusioni di un concertista
di Maurizio Bignardelli
Emanuele Krakamp (Palermo 1813 – Napoli 1883), uno dei più celebri concertisti italiani di flauto dell’Ottocento, trascorse due anni burrascosi della sua vita (1853 – 1855) a Firenze , in un esilio volontario causato dalla sua partecipazione ai moti politici del 1848 a Napoli contro il regime borbonico, e la successiva partecipazione alla battaglia di Velletri nel 1849 all’epoca delle campagne garibaldine della breve ed effimera stagione della Repubblica Romana .
Ricercato dalla polizia borbonica quale attivista politico ed agitatore, riparò nel Granducato di Toscana, forte di protezioni massoniche, e stabilì la sua residenza a Firenze in Via dei Calzajoli 799.
Qui poté tranquillamente continuare la sua attività artistica e si esibì in numerose accademie fiorentine, che vennero organizzate in palazzi privati per un pubblico scelto e selezionato. Queste esibizioni strumentali vennero recensite da diverse Gazzette Musicali e fogli periodici che a Firenze abbondavano. Si tratta di cronache musicali locali, che lette oggi, possono spesso apparire ingenue, condite di campanilismo, talvolta imprecise e lacunose nelle informazioni che forniscono, ma che comunque consentono di visualizzare l’attività nebulosa ed inquieta del nomadismo concertistico di Krakamp, e in alcuni casi giungiamo ad individuare (o ipotizzare) le composizioni musicali eseguite, e partecipare così idealmente questi due anni di permanenza fiorentina, sofferta e costellata di polemiche.
Ma oltre alle notizie ricavabili dalle gazzette musicali e fogli periodici, il recente catalogo digitale di casa Ricordi permette di dare una datazione precisa alle opere a stampa di Krakamp, mentre la furibonda polemica organologica scatenatasi pro o contra il sistema Bohm, è già stata ampiamente studiata da molti studiosi e quindi non entreremo in quella specifica diatriba.

Krakamp diede il suo primo concerto pubblico a Firenze , nella sede della Società Filarmonica di Firenze il 7 luglio 1853.
Il Direttore del Conservatorio di Firenze (annesso all’Accademia di Belle Arti), Ermanno Picchi (1811 – 1856) , fondatore nel 1853 della Gazzetta Musicale di Firenze, foglio settimanale, criticò questo debutto a Firenze di Emanuele Krakamp che si esibì con due brani per flauto e pianoforte: una Fantasia su temi napoletani (non meglio identificata) ed una Fantasia su motivi della Sonnambula di Bellini (che potrebbe essere la Sesta fantasia da concerto già pubblicata da Ricordi nel 1850).
Il concerto di Krakamp venne biasimato, non tanto per la sua incapacità tecnica come flautista – Krakamp era già un concertista noto a livello internazionale – ma per avere rotto nel sentimento del pubblico fiorentino l’incantesimo della voce flautistica di Cesare Ciardi, in quel momento lontano per giri concertistici in Russia, ma sempre caro e presente fra i melomani fiorentini per il fascino timbrico della sua voce flautistica (ovvero il “cantabile” proprio del flauto sistema Ziegler discendente al La grave sotto il pentagramma).
Quindi a sfavore di Krakamp , la sua arte flautistica venne contrapposta a quella di Cesare Ciardi, e l’evidente campanilismo di Ermanno Picchi diede formalmente inizio all’avversione verso il sistema Bohm. (1)
Dunque Krakamp era reo di offuscare la fama ed il prezioso suono di Cesare Ciardi, tanto amato dal pubblico fiorentino.
Eppure Cesare Ciardi, nonostante i fregi cavallereschi, i pubblici encomi, la sua numerosa famiglia, oltre ad essere membro della Cappella Granducale, cercò sempre ingaggi e gratificazioni più sostanziose, e non esitò ad allontanarsi progressivamente con numerosi viaggi concertistici, fino ad emigrare definitivamente in Russia , alla caduta del Granducato di Toscana.
Tale emigrazione fu favorita ed accelerata dal pianista e compositore Anton Rubinstein, che residente a Firenze, selezionò i futuri docenti del Conservatorio di San Pietrogrado .
Krakamp quando giunse a Firenze nel 1853 era già un concertista di flauto celebre in tutta Europa, e pertanto le critiche delle testate fiorentine non poterono che concentrarsi unicamente sul modello di flauto da lui suonato, che era un sistema Bohm (secondo brevetto del 1847 poi premiato nel 1855 all’Esposizione Internazionale).
Dopo questo primo esordio così ostile, nel 1854 Krakamp si esibì nuovamente in sette nuove Accademie, e anche in queste occasioni la stampa periodica fiorentina le segnalò puntualmente. Il 21 febbraio 1854 si esibì al Teatro Nuovo con un imprecisato “Solo per flauto” composto espressamente per lui da Francesco Saverio Mercadante” (impossibile risalire al brano) . (2)
Il 5 marzo successivo si esibì nella Sala Musicale del giornale “L’ Arte“ con due Fantasie per flauto e pianoforte: una su motivi della Semiramide di Rossini (che ipotizziamo possa essere l’op. 158 della Raccolta “Settimana Rossiniana”, successivamente pubblicata da Ricordi nel 1858 ) ; l’altra Fantasia venne ignorata dalla lacunosa segnalazione della Gazzetta (3).
Ancora il 24 marzo, ritroviamo Emanuele Krakamp insieme al pianista Carlo Ducci, uno dei migliori allievi della scuola pianistica privata del Barone Alexander Kraus , per l’esibizione di due Fantasie rossiniane per flauto e pianoforte (sulla Semiramide (ancora op. 158?) , e sul Mosè in Egitto (l’ op. 16 ?) .
La Sala “Kraus” , ovvero il salone musicale della villa privata del pianista dilettante Alexander Kraus (Francoforte 1820 – 1904), Barone Console di San Marino, stabilitosi a Firenze già nel 1839, era la scena di innumerevoli esperimenti cameristici ed i concerti furono frequentati dagli intellettuali più colti della Società fiorentina.
Kraus fu anche un orientalista, e l’iniziatore di un poderoso collezionismo musicale, raccogliendo una grande quantità di pianoforti e strumenti, anche
extra europei, che poi il figlio sistematizzò in un vera e propria Collezione Musicale etnografica . (4)
Kraus fondò inoltre la Società di mutuo soccorso fra gli artisti di musica, e spiccò fra i fondatori della Società del Quartetto. Per le sue caratteristiche intellettuali era inevitabile l’incontro con Emanuele Krakamp, libero muratore, futuro fondatore a Napoli della Società del Quartetto (alla caduta dei Borbone).
La Sala Kraus divenne sin dal 1847 un punto di riferimento obbligato per tutti gli esperimenti cameristici di musica strumentale a Firenze. (5)
Per questo nuovo concerto di Krakamp in casa Kraus , Ermanno Picchi Direttore e critico musicale della Gazzetta Musicale di Firenze, viste le amicizie influenti ed altolocate esibite da Krakamp , si guardò bene dal criticarne le esecuzioni, come aveva fatto incautamente l’anno prima, e stavolta le lodò incondizionatamente. (6)
Forte di questa saldatura con Kraus, che a Firenze godeva di stima e fama grandissima, Krakamp si esibì a novembre 1854 al Teatro Pagliano (con una non precisata composizione), e successivamente il 3 dicembre (secondo alcune fonti), o il 9 dicembre (secondo altre) ancora nella Sala Kraus con il pianista Carlo Ducci per la Fantasia su motivi della Luisa Miller di Verdi (pubblicata da Ricordi nel 1853 come opera a quattro mani con il pianista compositore Carlo Andrea Gambini (Genova 1819 – ivi 1865).
Stavolta non si trattava di un brano per flauto con un blando accompagnamento pianistico, ma per l’importanza ed il virtuosismo della parte pianistica, di un vero e proprio Duo Concertante. (7)
Nello stesso concerto Krakamp eseguì un quartetto per flauto, violino, violoncello e pianoforte su motivi del Macbeth di Verdi del compositore Salvatore Pappalardo (Catania 1817 – Napoli 1884) (che ebbe la sua prima proprio a Firenze Teatro La Pergola nel 1847).
Gli esecutori oltre a Krakamp furono Giulia Scheppard al violino, Mussini al violoncello e ancora Carlo Ducci al pianoforte. Pappalardo sarà uno dei musicisti chiave per le future iniziative di Krakamp a Napoli. Pappalardo con le sue composizioni cameristiche fu il vincitore di un Concorso per nuove composizioni in seno alla neonata Società del Quartetto. (8)
Il 10 dicembre (per alcuni giornali) o il 13 dicembre (per altri) , ancora nella Sala Kraus, venne eseguita una Gran Fantasia di Teodulo Mabellini per Tromba, clarinetto, flauto, trombone e corno con accompagnamento di orchestra.
La Gran Fantasia fu composta nel 1846 per ordine del Granduca di Toscana in occasione dell’insediamento dei Solisti della sua cappella Musicale: Cesare Ciardi (flauto) , i fratelli Bimboni (clarinetto e trombone), Francesco Paoli (corno) ed Enea Brizzi (tromba). (9)
Krakamp replicò nella Sala Kraus il brano di Mabellini con i migliori solisti presenti in quel momento sulla scena fiorentina (Enea Brizzi trombettista (Isola del Giglio (LI) 1821 – Barberino di Mugello 1886) a partire dal 1856 Direttore della Banda della Guardia Nazionale ; Giovanni Bimboni clarinettista nato a Firenze nel 1813 e morto nel 1893, Accademico delle Belle Arti e docente di clarinetto nel futuro Conservatorio sino al 1891; un tale Banchelli, segnalato nel 1841 nell’organico della Banda Strumentale Volontaria detta del Collegio, ed un certo D’Aloe . (10)
Krakamp poi completò l’Accademia con le Variazioni per flauto e pianoforte sul Ranz de vaches di Theobald Bohm (anche in questo caso impossibile risalire al brano ); il critico musicale elogiò le interpretazioni di Krakamp. (11)
Nel 1856 questa Gran Fantasia per quintetto di Fiati solisti ed orchestra venne ancora replicata a Firenze con gli stessi solisti del 1846, ovvero Cesare Ciardi al flauto, i fratelli Bimboni (clarinetto e trombone ), Enea Brizzi (tromba), Francesco Paoli (corno), segno che la vera rivalità per l’ambiente musicale fiorentino era rappresentata dal flautismo di segno opposto dei due solisti: Cesare Ciardi da un lato (osannato dai fiorentini e virtuoso del flauto all’antica, ovvero del flauto sistema Ziegler discendente al la grave) ed Emanuele Krakamp dall’altro.
Inutile sottolineare che Krakamp venisse presentito dall’ambiente musicale fiorentino come perturbatore dei delicati equilibri estetici vista la sua continua presenza nei luoghi topici del concertismo cittadino.
Krakamp era proteso nell’affermazione (a tutti i costi) del flauto sistema Bohm e in questa sua battaglia personale venne sostenuto dalla rivista fiorentina l’Arte con gli articoli di un anonimo giornalista che si siglava SRG . (12)
Il 17 dicembre 1854 Krakamp si esibì ancora per la Società Filarmonica con una Fantasia Militare per flauto e pianoforte (opera non identificabile anche se esiste un manoscritto con tale titolo presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli). (13)
Le invidie e le rivalità si fecero sempre più evidenti e la polemica organologica montò proprio in concomitanza dell’ultimo concerto fiorentino di Krakamp, 5 maggio 1855, nella Sala musicale della Rivista L’Arte. Programma musicale “Le Tre Grazie per flauto e pianoforte” (??), probabilmente “The Three Sister of England, Scotland and Ireland“ per flauto e pianoforte op. 106 (pubblicata da Ricordi nel 1853).
Questo concerto con il flauto d’argento sistema Bohm commissionato da Krakamp a Theobald Bohm e da questi ultimato il 15 marzo 1855 e spedito direttamente da Monaco a Firenze all’indirizzo fiorentino di Krakamp , fu la goccia che fece traboccare il vaso .

Il flauto numero 90 (venduto per 160 fiorini ) pervenne pochissimo tempo prima del concerto, segno che Krakamp manovrasse la diteggiatura con grande disinvoltura a differenza di tutti i suoi detrattori (14).
La Rivista L’Arte per effetto di questo esperimento scatenò una polemica vigorosa pro sistema Bohm schierandosi decisamente contro il partito compatto dei Conservatori che contava tutti i tenaci oppositori del flauto sistema Bohm in Italia .
Tutte le parti lese scesero in campo per diatribe che durarono anni (ed estenuanti) : i flautisti Raffaello Galli Tassi, Giulio Briccialdi, che pure era in posizioni rispettose nei confronti di Krakamp, e vennero coinvolti, loro malgrado, Giuseppe Rabboni e Luigi Marini propugnatori del sistema antico, grandi maestri riconosciuti ma incapaci di adeguarsi al nuovo sistema Bohm. (15)
La polemica durò ancora a lungo con echi estenuanti nelle gazzette musicali, stavolta non solo a Firenze, ma a Napoli e Milano. (16)
Nel 1855 casa Ricordi pubblicò un brano in gramaglie di Emanuele Krakamp: l’Elegia funebre op. 140 per flauto e pianoforte, dedicata “ai 25.000 messinesi che dal 22 agosto al 13 settembre del feroce anno 1854 furono di colera mietuti, questa dolorosa armonia Emanuele Krakamp patriota desolatissimo da Firenze intonava”. (17)
Era era giunto il momento per Krakamp di lasciare Firenze e il suo vespaio di polemiche.
Krakamp rimase pur sempre in quegli anni un esule politico, sostenuto sì dalla massoneria internazionale, ma intuì che non era il caso di sovraesporsi ulteriormente , con questi clamori giornalistici.
Decise di allontanarsi non solo da Firenze, ma anche dall’Italia, per evitare la polizia borbonica, che ormai era sulle sue tracce, e partì nel settembre 1855 per l’Egitto, dove ad Alessandria d’Egitto, Tunisi , ed al Cairo vi erano le dirette emanazioni del Grande Oriente napoletano e proseguì all’ombra di quelle protezioni la sua attività musicale . (18).
Fra il 1856 ed il 1860 Krakamp proseguì il suo nomadismo inquieto peregrinando a Messina, Milano, Genova, Vienna, Nizza, Trieste, Parigi, Nizza, Marsiglia, con una attività concertistica frenetica e febbrile oggi ben ricostruita da uno studio recente ben documentato e dettagliato . (19)
Rientrerà a Napoli soltanto con la proclamazione del Regno d’Italia e la caduta definitiva del Regno delle Due Sicilie. Per sua fortuna vi ritroverà ancora saldamente insediato nelle cariche musicali cittadine Francesco Saverio Mercadante che, mutato il quadro politico e culturale, lo reinserì nella nuova organizzazione musicale napoletana.
Per Krakamp si concluse così l’arco più difficile e delicato della sua esistenza.
A Napoli proseguì le sue attività (attività didattica con poderosa produzione editoriale, e stesura di Metodi per i principali strumenti a fiato, creazione della Società del Quartetto, di una Agenzia Teatrale e Musicale, attività saggistica specializzata con la stesura del saggio “Progetto per la Riorganizzazione delle Musiche Militari del Regno d’Italia” (1863) .

Diradò fortemente le sue esibizioni concertistiche (ormai circoscritte soltanto a Napoli ed in occasioni intime e domestiche, favorendo così la crescita e l’affermazione musicale dei suoi allievi, fra cui emerse Alfonso Pagnotti, futuro Maestro di Leonardo De Lorenzo) . (20)
Insomma gli anni fiorentini, di amarezze e delusioni, furono superati da un ampio ventaglio di attività fruttuose e feconde sul piano artistico. Per sua fortuna venne definitivamente obliato il suo passato di agitatore politico e poté così continuare indisturbato la sua opera musicale fino ai suoi anni finali (morì a Napoli il 13 novembre 1883, a settanta anni, dopo essersi risposato in tarda età, ed aver avuto la gioia di un figlio a sessantacinque anni) .

Note al testo
- Il concerto di Krakamp nella Società Filarmonica fiorentina del 7 luglio 1853 fu redatta da Ermanno Picchi , GMF , I, N° 3, 14 luglio 1853 pp. 19-20 e riportiamo i tratti salienti di questa sua recensione critica : “Krakamp notissimo suonatore, eseguì due sue fantasie su Temi Napoletani e sulla Sonnambula.- Ben fatte le composizioni, specialmente la seconda , e bene eseguite; ma le orecchie del nostro pubblico sono avvezzate alla magia dei cantabili del Ciardi, e quantunque apprezzino ed ammirino le difficoltà d’esecuzione in altri, pure non vi riscontrano quel sentimento che tanto gli ha commossi nel Ciardi. Aggiungete ancora la diversità della voce del flauto alla Bohm suonato da Krakamp, da quello antico suonato dai nostri. Il qual flauto…..” non contenta in quanto al volume ed alla qualità della voce. La voce del flauto antico fa perdonarne i difetti, mentre la perfezione del flauto nuovo non fa perdonarne la voce. Almeno così ha giudicato il nostro pubblico.
- Scaramuccia / giornale – omnibus , anno III, N°16, 16 febbraio 1854, p. 3
- GMF, I, N° 39 , 9 marzo 1854, p. 156
- GMF, II, N° 42, 29 marzo 1854 p. 166-167. La recensione di Ermanno Picchi stavolta è molto positiva. Per la collezione Kraus cfr. Catalogo della Collezione Etnografico-Musicale Kraus in Firenze, Firenze, Tipografia di Salvadore Landi, 1901 , 29 pagine.
- Sull’importante collezione di strumenti musicali del Barone Kraus cfr. Maria Virginia Rolfo, Collezionismo ed eredità: attorno alle raccolte di strumenti musicali del Conservatorio “Luigi Cherubini” e dei Baroni Kraus , in , Firenze e la musica strumentale del secondo Ottocento : Abramo Basevi, Giulio Briccialdi, Cesare Ciardi, Firenze, 2021 , pp. 29- 36.
- GMF,II, n°42, 29 marzo 1854. A firma di Ermanno Picchi “Il Signor Krakamp suonò egregiamente due sue Fantasie sulla Semiramide e sul Mosè pezzi benissimo elaborati, pregevoli per condotta e specialmente per il modo con cui i pensieri rossiniani vi sono collegati e rifioriti”.
- GMM, , Anno XII, N°52, 24 dicembre 1854 , pp. 414-415.
- Su Salvatore Pappalardo Cfr. Enrica Donisi, Echi risorgimentali nella scuola violoncellistica di Napoli in Prima e dopo Cavour, la musica fra stato sabaudo e Unità d’Italia, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Napoli 11-12 novembre 2011, pp. 109- 114, con una ottima ricognizione delle opere patriottiche composte da Emanuele Krakamp ed il Concorso per nuove musiche vinto da Salvatore Pappalardo in seno alla Società del Quartetto di Napoli fondata da Emanuele Krakamp nel 1862.
- Sulla gran fantasia per quintetto di fiati e orchestra di Teodulo Mabellini Cfr . Claudio Paradiso, Catalogo delle opere di Mabellini, in Teodulo Mabellini Maestro dell’Ottocento Musicale Fiorentino, Società Editrice di Musicologia , 2017 , p. 479.
- Cfr. Alessandro Onerati, Strumenti a fiato nella vita musicale fiorentina dell’ottocento. Tesi di Laurea Firenze, a.a. 1994-1995, in particolare le preziose mini biografie dei fratelli Bimboni (pp. 241-242), Enea Brizzi (p. 245-246), e sulla Banda Istrumentale Volontaria detta del Collegio di cui nel 1841 faceva parte Banchelli (p.273). GMF, II, N° 30 , 4 gennaio 1855, p.118. “Il Signor Krakamp eseguì benissimo e da vero artista, Le Ranz des Vaches, variazioni per flauto di Bohm”.
- Cfr. Alessandro Onerati si occupa della polemica sorta fra la Rivista L’Arte e la Gazzetta Musicale di Firenze, op. cit. p. 62 e segnala che la polemica venne raccolta il un libretto dal titolo “Il periodico l’Arte che afferma, La Gazzetta Musicale di Firenze che nega: i vantaggi del flauto alla Bohm, Firenze Tipografia Benelli, 1855. In questa polemica Onerati tenta di identificare la sigla SRG e fa delle ipotesi.
- Cfr. Emanuele Krakamp Gran Fantasia Militare per flauto e pianoforte op. 162, Prima edizione assoluta a cura di Carlo De Matola e Emiliano Giannetti , Vigormusic, 2012. I revisori nell’introduzioni affermano che il manoscritto della composizione si trova presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.
- Per il flauto costruito da Theobald Bohm per Emanuele Krakamp Cfr. GianLuca Petrucci, Saggio sulla diffusione del flauto Bohm in Italia, Quaderni del Conservatorio di Milano, Edizioni Fa La Ut, 2006 p. 37; per l’individuzione del flauto n° 90 spedito da Monaco all’indirizzo fiorentino di Krakamp due mesi prima del concerto del 1855, Cfr. p.62 nota N° 11 e pagina 64 nota N°26.
- Cfr. GMF , II, N° 51 , pp202 e seguenti.
- GMN , Anno IV, N° 33 , 18 agosto 1855, pp. 261-262. Cfr inoltre GMF , III, N° 8, 2 agosto 1855,p.31 ed in seguito GMM, XIII, N° 28 e N° 29, 15 ottobre 1865 p. 5
- Emanuele Krakamp Elegia funebre op. 140, Ricordi n° lastra 27723, pubblicata nel 1855.
- Per le attività musicali svolte in Egitto, Cairo e a Tunisi Cfr. Maurizio Bignardelli “Flautismo e massoneria “ , in Emanuele Krakamp, Quaderni dell’Accademia Filarmonica di Messina, Messina, 1991, pp. 95-105. Per una lettura musicale massonica dell’Elegia funebre op. 140 Cfr. Maurizio Bignardelli, “Flautismo, Massoneria e Bande Militari nel Regno delle Due Sicilie: il caso Emanuele Krakamp (Messina 1813- Napoli 1883)”, in Francesco Florimo e l’Ottocento Musicale, Atti del Convegno Morcone, 19 – 21 aprile 1990 a cura di Rosa Cafiero e Marina Marino, Jason Editrice Reggio Calabria 1999, pp. 875-887.
- Cfr . Demetrio Chiatto, “La Famiglia Krakamp (Francesco, Giovanni ed Emanuele ) Messina 2022 pp. 51-58 (il volume è ricchissimo di spolio di riviste e gazzette d’epoca, aggiorna il catalogo delle opere, e pubblica tre composizioni musicali significative dedicate alla città di Messina o di natura patriottica.
- Su Anfonso Pagnotti , allievo di Krakamp e futuro maestro del giovane Leonardo De Lorenzo cfr Demetrio Chiatto op.cit. pp.166-167.
Maurizio Bignardelli
Website | Facebook
Diplomato presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma nel 1980 sotto la guida di Giancarlo Graverini, si è perfezionato con Aurele Nicolet, Maxence Larrieu, Severino Gazzelloni.
Laureato presso l’Università degli Studi di Bologna (1985) con una tesi di laurea su “Emanuele Krakamp (1813-1883), ha prodotto saggi, articoli, pubblicazioni musicologiche per riviste internazionali e revisioni musicali di opere flautistiche italiane dell’ottocento per numerosi case editrici (Ut Orpheus , Zimmermann, Bèrben, Da Vinci).
Ha partecipato a convegni internazionali e, come professore d’orchestra, ha lavorato nelle Orchestre Sinfoniche della RAI, del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Ente Lirico di Cagliari, dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha inciso 45 CD solistici e cameristici per note case discografiche,ottenendo premi dalla critica internazionale.
E’ docente di Flauto presso il Conservatorio “Respighi” di Latina.


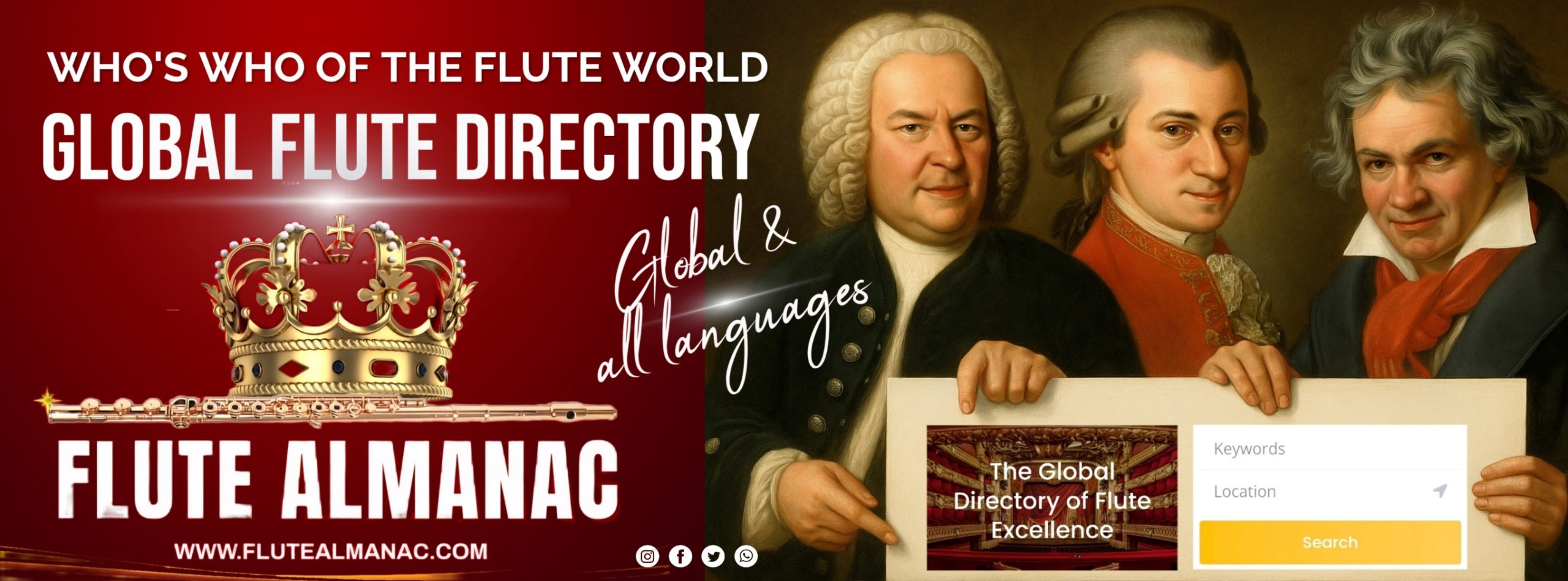






Maurizio Bignardelli, flautista e musicologo di grande livello, fornisce informazioni inedite su protagonisti della storia flautistica italiana.
Grazie!!